Storia di Un Impiegato, uscito nel 1973, contiene alcuni classici del repertorio di Fabrizio De Andrè, e tratta della discesa (o salita alla verità) verso l’ideale rivoluzionario di un comune impiegato tramite la Bomba. Pastorale Americana è, invece, un romanzo del defunto Philip Roth uscito nel 1997, che gli valse un contestato Pulitzer. In comune hanno il tritolo, come forma di affermazione di se stessi e di distruzione degli altri – due fenomeni interconnessi.
Uno degli album più discussi di Fabrizio De Andrè è stato, ed è, Storia di un impiegato. Fu recepito malissimo dalla critica specializzata dei tormentati anni ’70: venne giudicato verboso, difficile, ridondante, pretenzioso. L’odissea parabolica di un impiegato che passa dalla sanità mentale all’ossessione per la lotta, per la bomba, per la purezza del tritolo, all’odio per i krumiri : il rinnegare la religione, i patri confini, la famiglia – abbracciare un ideale che non sembra neppure essere tanto compreso dall’illuso, tristo, spiritato, impiegato protagonista. De Andrè raramente riproporrà i brani da Storia di un Impiegato, con l’eccezione per le sempreverdi Verranno a Chiederti del Nostro Amore e il Bombarolo, recentemente stuprato da Willie Peyote nell’”omaggio” – più che altro insulto – Faber Nostrum. Quest’ultima, brano abusato in modo vergognoso da tutti noi quand’eravamo adolescenti per la frase “C’è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo”, senza capire un cazzo del contesto socio-politico, dell’esistenzialismo de andreiano che otterrà la sua maggiore espressione in Non al denaro, né all’amore, né al cielo.
Ma che ne sapevamo? Cosa ne potevamo sapere, figliocci di un mondo borghese figlioccio degli anni ‘80 che caracollava verso l’abisso?
Quest’oggi, 24 novembre 2019, compio ventisette anni. Tanti anni aveva lo Svedese, Seymour Levov, protagonista di Pastorale Americana di Philip Roth, quando la sciagura della sua vita uscì dalla vagina di sua moglie, la piccola e bionda Merry.
L’impiegato di De Andrè è un uomo annoiato. Ha una vita perfetta ma noiosa: sicuramente un ottimo posto di lavoro, si presume da amministrativo in una fabbrica del Nord-Est, di certo non uno che si sporca le mani.
Un Fabrizio che non ha scelto la musica, che non è andato contro il volere del padre. Ha una bella compagna, una che fra tante “facce, grigne, musi” ha un volto: un volto televisivo, fotografico. Vivono nei tardi anni ’60, forse nei primi ’70: le BR ancora non terrorizzavano l’Italia, la lotta operaia non era ancora discesa nella sinistra – in ogni senso – violenza del caos. L’impiegato, viene rivelato in La Canzone del Padre, è figlio del nepotismo: ha ereditato il posto di lavoro del padre. È un vigliacco. È un privilegiato. Il ’68 è passato da anni, e lui cosa faceva? Ha ormai trent’anni, sarà così tardi per unirsi? Per far valere quell’ego che lui – lo sente, che gli morde le viscere, che spinge per uscire – ha soffocato sotto il perbenismo della borghesia, una “faccia usata dal buonsenso”?

L’impiegato ascolta, con colepvole ritardo, canti del ’68 francese. I francesi, loro sì, loro sì che le sanno fare le rivoluzioni. Mica come noi, sempre pizza e spaghetti e mandolino, relax come un Titiro del ventesimo secolo sotto all’olmo – che non vuole esser disturbato, e che preferisce sopportare che urlare. E l’impiegato macera e gorgoglia dissenso verso un potere cui sente di essere servo, così come suo padre, un potere che opprime la madre del povero amico Berto – lavandaia morta di stenti e seppellita in mezzo alle lavatrici cui aveva, a sua volta, dedicato la vita. Lavatrici che lindavano e inamidavano le camicie che l’impiegato indossa.
L’impiegato inizia a sognare: e se, invece che adagiarsi a quella bella vita fatta di Babbi Natale e belle compagnie, avesse scelto, anni prima, di far parte delle rivolte universitarie? Il senso di colpa lo attanaglia. Vorrebbe poter condividere, perlomeno, l’unità di misura morale con quei ragazzi, ma sente di non esserne degno.

E se, allora, invece che collettivamente, dall’alto dei suoi trent’anni, l’impiegato – forte del suo cuor di tritolo – quella rivoluzione, decantata da Marx e da Engels, riuscisse a farla da solo? La non-violenza delle rivolte sessantottine a cosa aveva portato?
A nulla.
Allora l’impiegato decide, dopo lunghe elucubrazioni fra una pausa caffè e un’altra, di cambiare approccio. E sogna la violenza della carne fatta di neutrini e sostanza dei sogni sanguinolenta dell’esplosione di Dante, Ariosto, Francesca, dei politici, l’ammiraglio Nelson, la Statua della Libertà – altra opera dei francesi che l’impiegato pare tanto invidiare – e scopre la vera parità, la vera equità, l’uguaglianza e fraternità che tutti unisce e colpisce: la tremenda morte casuale causata dalla bomba. Tutti muoiono: muoiono i padri fondatori dell’italica natura, muore suo padre, muore sua madre (creatura senza volto e sostanza) ma lui viene assolto. Il giudice lo assolve – perché quella violenza non può far altro che rafforzare il radicatissimo potere. Un potere che perde di significato, nel suo essere spaventosamente ripetuto, mai descritto, etereo come la quinta forza di una fisica rivoluzionaria cui l’impiegato a malapena conosce le formule base.
Merry Levov è una bella bambina, nel romanzo di Philip Roth. Nata da una ex miss, Dawn, e da l’idolo del quartiere ebraico di una Newark degli anni ’60, Seymour. Bellissimo, biondo, occhi azzurri, che eccelleva negli sport e nell’ambizione finanziaria – una ricca e prestigosa fabbrica di guanti, è la sua. Una vita perfetta: una splendida casa che si stende fra i pascoli di mucche, una bellissima moglie, una dolce bambina. Una natura gentile.
Ma quand’è che si rivela davvero in toto la natura umana – in un liberatorio tritolo?
La bomba ha uno strano fascino. L’ideale di essere responsabile della morte di altri esseri umani, ma mai davvero colpevoli – perché, per sua natura, la bomba, ha una natura “non gentile” ma neppure maligna – colpisce anche la labile ed ovattata mente della piccola Merry, che, come l’impiegato, scopre se stessa attraverso la violenza. Ascoltando le elucubrazioni di Angela Davis, attivista comunista americana, struggendosi per la guerra in Vietnam, fra amicizie poco raccomandabili – per la pastorale americana in cui Seymour crede così ferocemente – Merry, diciassetenne, posizione una di quelle cose esplosive alla stazione di posta del paesino in cui vive. Uccidendo un innocente.
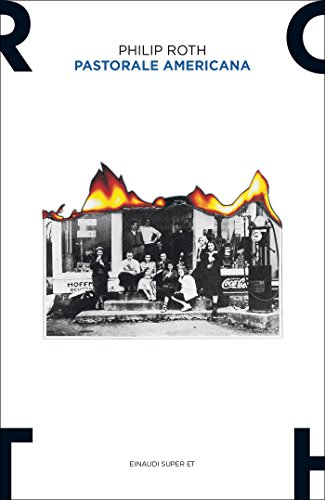
Merry non motiva, non si giustifica, ripete come un mantra le affermazioni distanti, distantissime, di attivisti che non la rispettano e la usano come pedina; l’impiegato, invece, si rintana nel suo individualismo e non ha nessuno che gli insegni a collegare gli incantati fili di un detonatore. Entrambi, però, sono bombaroli: ma distanti, nella loro natura e nella loro anima. L’impiegato è un idealista, è una persona colta, adulta, seppure confuso come Raskolnikov e febbricitante di follia omicida – pianta bombe su bombe in edicole e lettere sporche di sangue volano qua e là – e la piccola Merry, del capolavoro di Philip Roth, è una creatura antitetica alla gentilezza della pastorale americana. Una pastorale, un modus vivendi, che, già ad un primo acchito, è così diametralmente distante da quello europeo collaudato da secoli – cui è una stortura, un’illusione da presepe, l’aberrazione di un piccolo mondo antico che non esisteva neppure nei dopolavoro delle fabbriche del Nordest – e che non può essere altro che fonte di violenti contrari. L’impiegato di Storia di un Impiegato si adegua malamente alla vita che il padre gli ha consegnato, Merry la rifiuta senza una ragione precisa – perché la sua natura è caos incompleto. Non è il caos di un Joker, un malato di mente abbandonato da una società ingiusta, è il caos dettato dall’ignoranza piantata in un’anima fragile. E da noi, nella Vecchia Europa sulla sponda sporca – quella priva della pudicità columbiana – dell’Atlantico,
De Andrè crea un personaggio che ritrova in sè stesso il suo male, causato sì da un mondo fatato ricco di contraddizioni, ma che nasce, fondamentalmente, dal suo animo.
La natura umana in Storia di un Impiegato si rivela nella scoperta di sé tramite il tritolo; quella di Merry avviene, fra i pianti dolorosi del padre, in una topaia in cui si nasconde. L’impiegato rifiuta in un elegante ballo mascherato finito in tragedia i patri fondatori; Merry, americana ignorante allegoria di come Roth, ebreo coltissimo, vede la vacuità della ribellione al sistema ipercapitalistico statunitense, rifiuta la Costituzione, la bellezza della madre che l’ha generata, la tassazione e il libero mercato, i treni, il cibo di qualità e la libertà di ingrassare, senza realmente interiorizzare ed apprezzare ciò.
Il perché Storia di un Impiegato di Fabrizio De Andrè non sia stato apprezzato fin tanto che il cantautore era in vita appare oramai chiaro. L’invito, finale, alla rivoluzione contro i carcerieri, appare posto in una dimensione mistica che i contemporanei non avevano la fantasia per immaginare. Poteri buoni non ce ne sono, nemmeno i rivoluzionari lo sono.
La bomba non ha una natura gentile e può distruggere anche i piccoli dettagli che ci tengono ancorati alla sanità mentale: Seymour viene frantumato dalla bomba, la società italiana no.
Quand’è che si rivela, davvero, la natura umana?
Leggi anche
5 consigli per realizzare un album fotografico fai da te
Lúcio Rosato, Trilogia della possibilità in Mostra al MuMi
Premio Michetti, 75 anni di arte e cultura
I migliori concerti all’interno dei casinò: ecco le grandi star che si sono esibite
Numeri da record per i capolavori di Monet in mostra a Padova fino al 14 luglio
Miracoli e tradimenti nel nuovo libro di Valeria Parrella [Recensione]
Bologna Children's Book fair: impressioni a freddo
Alla scoperta del mondo attraverso la letteratura di viaggio
- March of the Unheard, Halo Effect: recensione - Gennaio 19, 2025
- Intervista a Tamas Katai, Thy Catafalque: il nuovo album, il passato, l’autunno - Novembre 9, 2024
- Kamelot live al Kino Siska di Lubiana, 19 ottobre 2024: live report - Ottobre 20, 2024
