Dopo le roboanti acclamazioni e i panegirici nei vari festival da parte della critica e della stampa arriva anche nelle sale nostrane “La zona d’interesse”, il nuovo film di Jonathan Glazer prodotto dalla ormai arcinota A24 e distribuito da I Wonder Pictures. Solita minestra riscaldata di cinema dell’orrore gentrificato per hipster oppure siamo dinnanzi ad un film meritevole?

Sono passati ben dieci anni da “Under The Skin” (Jonathan Glazer, 2013), il precedente lungometraggio di Jonathan Glazer. Un decennio è un tempo bramato da ogni artista per sfuggire dalle opprimenti leggi di mercato e di produzione; un tempo che permette di meditare, rielaborare, scuotersi e comprendere in profondità se è concreto il desiderio del dire un qualcosa. In realtà, anche se il nuovo film di Glazer arriva dopo dieci anni, il regista si è mosso fin da subito per le ricerche che si annoverano già dal 2014.
Dopo la lettura dell’omonimo romanzo di Martin Amis dal quale prende ispirazione, il regista rimane colpito dai fatti ma non dal racconto; cerca quanto più realismo possibile e per lui, infatti, il grande problema sono proprio gli elementi di finzione che caratterizzano il romanzo di Amis: dal primo comandante Höß, così come tutti gli altri personaggi esistenti nel romanzo, chiaramente piegati alle esigenze del racconto; fino alla presenza di una tresca d’amore impossibile tra un Sonderkommando e la moglie Höß. Glazer, allora, setaccia il più possibile il romanzo di Amis basandosi soprattutto sull’autobiografia composta da Rudolf Höß durante il periodo di prigionia e prima di essere condannato a morte per impiccagione. Sempre più spinto da una ricerca del reale, Glazer trascorre anni di ricognizioni sul campo andando in Polonia e studiando il repertorio degli archivi del Auschwitz-Birkenau Museum. Il risultato? È un film quasi impossibile: accuratissimo pur non mostrando nulla.

Glazer inscena la storia di Rudolf Höß, il primo comandante del campo di concentramento di Auschwitz, e della sua famiglia nella loro più totale spensieratezza mentre dimorano in una lussuosa villa, in un paesaggio bucolico proprio accanto al campo di concentramento di Auschwitz. La scelta della villa in quella posizione non è una ricostruzione scenografica ma storica: le alte leve della macchina nazista puntavano, infatti, nella costruzione di un sito dal nome “Interessengebiet” (Zona d’interesse): una grande area di espansione politica e sotto il controllo diretto dei nazisti, al cui interno convivevano residenze e campi di concentramento con l’obiettivo di arrivare a ritagliarsi un “Lebensraum” (Spazio vitale”) ad Est della Germania, come viene anche menzionato nel film. In questa zona, la tenuta degli Höß era la più vicina al campo di concentramento di Auschwitz e a separarle c’era solo un muro.
Un muro che squarcia e divide impossibilitando la visione e il trapasso ma, che allo stesso tempo, funziona anche da giuntura che rende l’inferno del campo di concentramento e del paradiso della villa Höß spazi contigui; non a caso la villa degli Höß con annessa piscina ricorda in tutto e per tutto l’Eden, rievocando iconograficamente anche la fonte della giovinezza nella quale i ragazzini fanno il bagno. Allo spettatore viene mostrato solo questo lato del muro: la storia paradisiaca della famiglia Höß e, quindi, delle frivole e spensierate giornate di una famiglia assai benestante che affronta banalissimi problemi quotidiani quali curare il proprio giardino, seguire le ultime mode, assicurarsi che i figli crescano sani, etc; dall’altro lato, invece, c’è la storia infernale che non viene mai mostrata allo spettatore ma sempre udita.
Fondamentali sono le riflessioni di Primo Levi, il quale scriveva che:
«Höss è stato uno dei massimi criminali mai esistiti, ma non era fatto di una sostanza diversa da quella di qualsiasi altro borghese di qualsiasi altro paese; la sua colpa, non scritta nel suo patrimonio genetico né nel suo esser nato tedesco, sta tutta nel non aver saputo resistere alla pressione che un ambiente violento aveva esercitato su di lui, già prima della salita di Hitler al potere».
Glazer, allora, non realizza un film storico, un film da museo; l’intenzione è quella di realizzare un’opera pulsante; di aspirazione universale e dalla quale non ci sentiamo ormai al sicuro con la scusante: “eh, erano altri tempi”. No, quei soprusi non sono lontani nel tempo e soprattutto non sono stati perpetrati da persone dissimili da noi. Dopotutto, l’antisemitismo non è di certo stata un’invenzione dei Tedeschi, qualche decennio prima c’erano stati i Russi con uno dei falsi storici più importanti di sempre “I protocolli dei Savi di Sion”. Glazer, allora, ricalca le somiglianze tra lo spettatore e i perpetratori piuttosto che tra gli spettatori e le vittime.
“La zona d’interesse” è un film che mi ha fatto pensare al “grande cinema” – ovviamente non sto parlando di quello indipendente – ormai sempre più massimalista. E insomma, si sentiva proprio il bisogno di un autore che compiesse delle scelte significative sul linguaggio. Grazie al lavoro svolto dal sound designer Johnnie Burn – già collaboratore fisso per Yorgos Lanthimos e in “Nope” (Jordan Peele, 2022) – spendendo mesi di tempo nella catalogazione dei suoni di Auschwitz e partendo proprio dalle testimonianze dei sopravvissuti contenute negli archivi. Il sound design di Johnnie Burn crea una storia dentro la storia; una scenografia sonora che collide con quella visiva in un costante gioco di auricolarizzazione esterna – termine suggerito dallo studioso Michel Chion – per cui i suoni diegetici del film vengono effettivamente percepiti dai personaggi pur essendo semanticamente vuoti, non rivestendo un significato alcuno.
L’effetto creato è di straniamento: lo spettatore è disorientato. Del resto, la sensazione di sbigottimento viene messa in chiara fin da principio: nel titolo di testa del film, la compositrice Mica Levi performa circa tre minuti di una sua partitura sopra un frame nero; quasi come se il film non cominciasse mai. Una scelta anticonvenzionale ma efficace che immerge lo spettatore in una musica cupissima, un’ondata sonora che ammanta il primo muro nero nerissimo. La sensazione è quasi che si apra un valico verso un buco nero dal quale lo spettatore verrà risucchiato e, allo stesso tempo, anche un telo sul quale proiettare i peggiori incubi della storia umana.
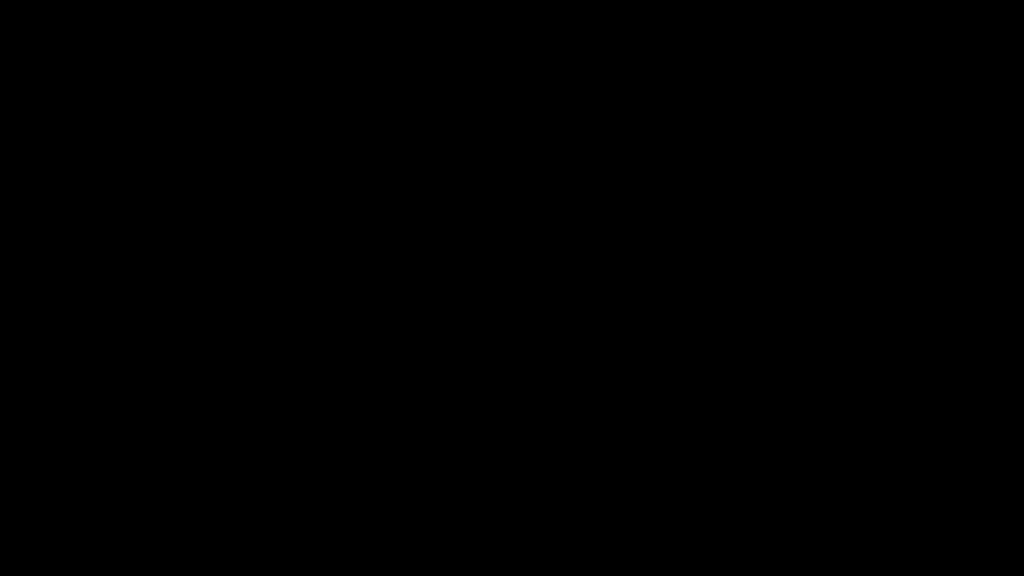
Tra l’altro, la compositrice Mica Levi aveva preparato più tracce ma Glazer ha optato solamente per utilizzarne due: ad inizio e fine visione. Un taglio, quindi, che non risponde ad una mera scelta di economia; quanto, piuttosto, all’uso di un linguaggio ben preciso fatto di tante inquadrature frontali e fisse; prevalenza delle sequenze sulle scene; campi lunghi e figure intere; pochissime carrellate e movimenti di macchina; profondità di campo infinita e controcampi che non vengono mai mostrati. Sul set della fedelissima ricostruzione della dimora Höẞ, Glazer posiziona nelle varie stanze e per il corridoio dieci camere e microfoni nascosti e impercettibili; poi, controlla tutto a distanza dai suoi schermi, optando per un montaggio serrato delle varie riprese.
L’uso del multicamera così utilizzato ricorda proprio quella di un circuito di videosorveglianza e, in corso d’opera, risulta fondamentale per restituire nella maniera più genuina possibile la naturalezza del quotidiano famigliare. Così facendo, durante le riprese, gli attori non si trovano dinnanzi ad una troupe e sono liberi di girare sul set, inscenando più genuinamente la quotidianità borghese di una famiglia. Inoltre, grazie a questo espediente, ne risulta potenziata anche la sensazione di voyeurismo da parte degli spettatori, intercalati nei panni degli impiccioni e degli ospiti sgraditi della tenuta Höß. Un’altra regola importante che utilizza il regista è quella dell’eliminazione totale dell’illuminazione artificiale: il male, nella sua banalità e nel suo costante perpetrarsi, agisce sempre sotto la luce del sole, in piena visibilità.
Addirittura, il regista opta per l’utilizzo della camera termica per girare alcune scene in esterni e in notturna pur di non infrangere il divieto dogmatico dell’uso dell’illuminazione artificiale. In queste scene, quasi dal piglio fiabesco, vediamo una delle figlie degli Höß che rifulge segretamente dalla dimora e distribuisce delle mele sui campi di lavoro. L’uso del negativo, quindi, non è solo una scelta stilistica ma allude in maniera suggestiva e metaforica alla creazione di un mondo parallelo, opposto rispetto al “positiv” della realtà di tutti i giorni. Tutte queste scelte, insieme alla profondità di campo infinita portano ad una visione nitida, chiara, senza sovrainterpretazioni, non caricaturale, priva di manipolazioni di quanto viene rappresentato e fedele ai precetti di André Bazin. Una vera e propria spogliazione di tutti gli elementi finzionali.

Se Glazer nel suo precedente film “Under the Skin” mostrava il male come densissimo liquido mercurico che ricorda il grafene – un’iconografia abbastanza ricorrente nel cinema e soprattutto nella televisione, basti pensare che troviamo questa rappresentazione del male in Severance, Stranger Things, X-Files, Star Trek: The Next Generation e chi più ne ha ne metta -trasalendo questa rappresentazione, il concetto è che il male nel suo essere informe può assumere diverse forme, è proteiforme. Se in Under The Skin assumeva sembianza umana e tentatrice per cibarsi dell’essenza vitale altrui; ne “La zona d’interesse” non è un mutaforma, piuttosto, una sostanza insita in ogni forma vivente.
A circa metà film, lo spettatore viene posto dinnanzi ad una colonna visiva di dettagli sui fiori della tenuta Höß, mentre, la colonna sonora ci fa “vedere” urla e sgomento delle atrocità commesse nel campo di fianco. La vastisissima valenza simbolica dei fiori di bellezza, ottimismo, speranza, amore viene svuotata da qualsivoglia senso. I fiori assistono impassabili, inermi, esattamente come il cinguettio melodico degli uccellini e il cielo azzurro di nuvolette che si erge granitico al di sopra del muro invalicabile della tenuta Höß. Una sensazione di perturbamento ci invade: il fiore, nella sua impassibilità, nella sua fiera maestosità e nelle sue dimensioni sproporzionate rispetto a quelle alle quali siamo abituati. Ed è ancora più spaventoso se pensiamo che in una sequenza ci viene mostrato un Sonderkommando spargere le ceneri dei detenuti per concimare proprio quei terreni.

Un qualcosa che ricorda un po’ la scena iniziale dei tulipani rossi in “Velluto Blu” (David Lynch, 1986), il quale li inquadra quasi come presagio di un grosso incidente domestico che accadrà poco dopo. Lo svuotamento della carica simbolica positiva di questi elementi è perturbante ed efficace nella veicolazione di quello che è il grande elemento di orrore del film e dell’essere umano: l’indifferenza dinnanzi alle atrocità, l’impassibilità che la famiglia Höß mantiene durante tutto il periodo di villeggiatura fatto di tonitruanti urla di strazio che non deturpano il loro quotidiano e non vìolano i penetrali dell’anima. La zona d’interesse che diventa una zona di disinteresse. L’orrore traslato dalle fucilazioni e dalle tumulazioni di cadaveri alle scarpe ammucchiate agli indumenti; gli oggetti personali sottratti ai deportati e indossati capricciosamente e con nonchalance dalle mogli degli ufficiali nazisti; i Sonderkommando costretti a disseminare le ceneri dei propri cari per avere qualche giorno di vita in più. Nella sua rimozione, più horror vacui di così il film non poteva essere.
Leggi anche
5 Film che svelano i segreti del gioco d’azzardo professionistico
I Peccatori: da quando ai vampiri piace cantare? | Recensione
David di Donatello 2025, Vermiglio miglior film: Delpero premiata come miglior regista
David di Donatello 70, le candidature: Sorrentino fa il pieno, tre donne per il miglior film e regia
Opus di Mark Anthony Green: recensione
Il Gattopardo - La nuova serie di Netflix
Il Seme del Fico Sacro: recensione
Il Giappone sulle orme di Kōji Yakusho, protagonista del capolavoro Perfect Days
- La zona di (dis)interesse – Recensione - Marzo 4, 2024
- Dead Ringers: la serie è il gemello cattivo del film di Cronenberg [Recensione] - Maggio 19, 2023
- Lucid Dream Festival 2023: sbarca a Pisa il festival che avete sempre sognato - Marzo 4, 2023
